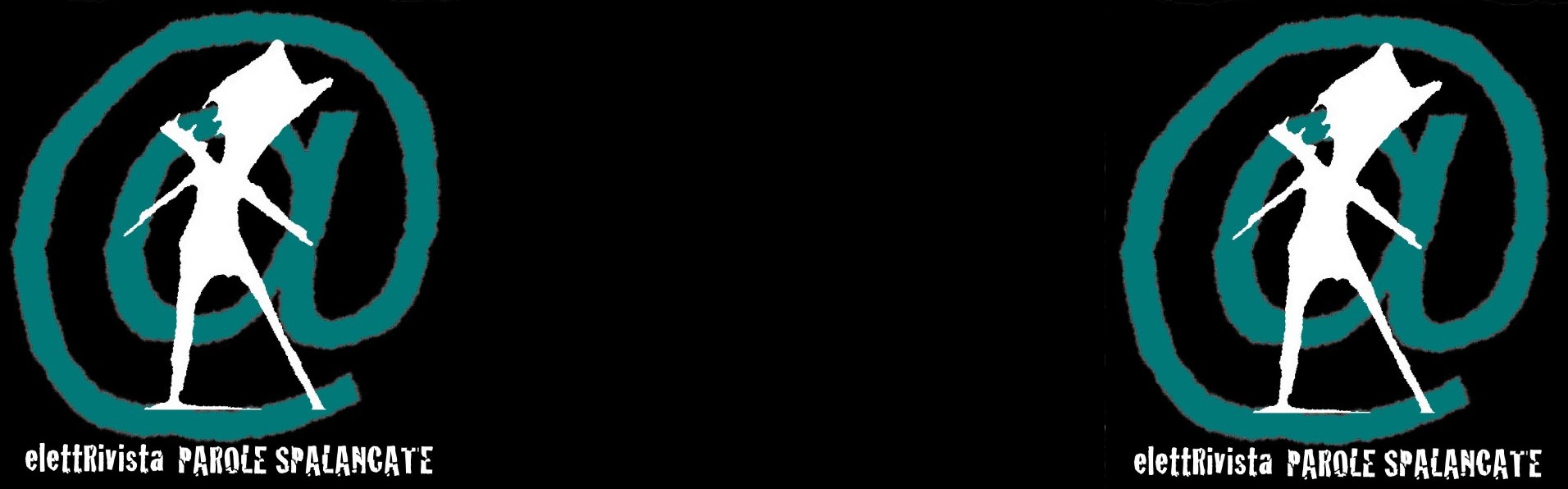15 Dic Classici contemporanei
CLASSICI CONTEMPORANEI
Rubrica di Marco Ercolani*
REMO PAGNANELLI
Quasi un consuntivo. Poesie 1975-1987
Donzelli, 2017

«Mai stato un giorno senza paura,
senza la luminosa paura
di essere dimenticati.
Perciò ora che all’alba
me ne rimango nell’attesa,
sapendo già che tutto è scontato.
[…]
Così si vuole che
il mio genio fosse incompreso
perché la ragione è chiara e lo vedono
tutti che non andavo d’accordo con la Storia e
così il mio biografo si lamenta
della mancanza di fatti notevoli
e prepara la tesi all’opposto, il grosso
avvenimento sarebbe la mancanza di questi».
Studioso della poesia del Secondo Novecento (da Milo De Angelis a Eugenio De Signoribus), autore di saggi sull’opera di Vittorio Sereni e di Franco Fortini, critico attento e spesso non allineato alle idee dominanti, studioso di psicoanalisi e di linguistica strutturale, Remo Pagnanelli, da Epigrammi dell’inconsistenza a Preparativi per una villeggiatura, realizza una scrittura elegiaca, fredda, inattuale, attenta ai dettagli delle cose, da cui l’io sembra già programmaticamente assente. I “lampi di una bellezza greca” che intravede nella poesia di Penna sono già, per lui, come reliquie. Remo era “una mente acuta” (De Angelis) e addolorata dalla malinconia (“l’anno ha pochi giorni perfetti”); per lui le immagini del poetare venivano dopo un lungo lavoro critico.
Scrive Pagnanelli:
«La poesia non è più metafora di altre cose, non rimanda che a se stessa, alla noia di un profluvio di parole che conducono da un lato alla completa afasia o nel migliore dei casi a una fenomenologia delle assenze nella elencazione di oggetti e sul piano esistenziale alla follia e al suicidio». La noia delle parole che conduce all’afasia: un plus verbale dominato da un minus esistenziale. La sua idea della vita è marcata da un dolore senza ritorno: «stagnazione perenne dell’umano, suo stigma inestinguibile, muraglia brulicante male. In questo fango, similmente a Giona, si mira a un eventuale accesso alla grazia o alla pietà».
E, in Consolazioni (per gli dèi), scrive, rivolgendosi agli stessi dèi, afferma: « – e se foste voi a chiamare, / a invocare l’intervento, / se bastasse la parola o la rima / perché vi si nomini; / e si volatilizzi la rete / che v’imprigiona?».
Sono gli dèi a chiamare, a rompere la rete. Le esperienze intriganti dell’arte non si producono nella normalità dell’umano. Al contrario, è proprio l’avversione all’ortodossia a inventare nuove fantasie, che a loro volta inventano e progettano nuove forme. Non si è mai oggettivi, se si guarda con i propri occhi. Volente o nolente, l’uomo deforma il mondo, lo accorcia o lo allunga, lo allarga o lo restringe. Tutta la nostra vita è dominata dal più o dal meno. Il ‘tono medio’ dell’adattarsi, del consentire, dell’obbedire, è inadatto a spiriti liberi, e alla poetica di Remo. Artisti, matti, bambini, non stanno nei limiti. Esagerano, turbano. Indisponenti, non consenzienti, privi di una regola a cui accordarsi, se ne inventano una nuova. Ulisse e i suoi marinai si legano agli alberi della nave con le orecchie turate dalla cera per non sentire il canto ammaliante e letale delle Sirene. Ma Ulisse ascolta, è il solo ad avere le orecchie libere dalla cera. Lui le sente, quelle voci stregate, ma si vieta di sprofondare nel loro sortilegio: se ne lascia pervadere senza smarrirsi. Remo no. Pervaso dall’ossessione della morte, nella morte si smarrisce, come nella chiusura di un cerchio:
«…tuttora mi aliena
l’idea consolatoria di una gita dietro
le ombre, da girare altrove su battelli,
tra fiumi erbosi fino allo spiazzo degli Elisi»
Ogni discesa agli inferi – non come malattia psichica ma come esperienza di follia, senza soluzioni già formulate – è poesia, nel proprio mondo interno di immagini, simboli, analogie. Poesia come arma per difendersi dal pericolo della follia. Emily Dickinson scrive: «Poi un’asse si spezzò nella ragione/ ed io precipitai sempre più in fondo».
Gilles Deleuze aggiunge: «Lo scrittore in quanto tale non è malato ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo». Queste parole ci ricordano che ogni scrittura è “un’impresa di salute” che nasce dal male di vivere, un’impresa estrema in cui rappresentare sulla carta, con versi sibillini o realistici, analogie estranee alla percezione dei sani, mondi tenebrosi e altri dai quali si può ritornare, pur tramortiti, scarabocchiando versi, ma nei quali è anche fatale sprofondare irreversibilmente, come accadde a Remo, desolato critico della poesia contemporanea.
«Esiste un lago che ogni notte
mi chiama e invita a immergere i piedi fra le alghe,
se poi optassi per un bagno completo,
fremerebbero di gioia tutte le canne delle sponde»
Il malinconico disincanto di Remo è il punctus del suo essere poeta: nell’attimo in cui il desiderio, decreta viene espresso decreta la fine dell’io. La gioia registrata dai suoi versi è solo il fremito delle canne – oggetti del mondo dove la vita si è trasferita, non palpiti del corpo. La vita del poeta resta assente. Presente, sempre, il suo fantasma:
«Mia ombra mio doppio,
talvolta amico ma più spesso
straniero che mi infuria ostinato,
mio calco che nessuna malta riempie,
fantasma appena colto,
di te ho centinaia di fotogrammi
sfrenati dalle corse, trattenuti
nelle reti, mio ombrello protettivo
paratutto, già cieco già binomio d’altro,
convengo con te quel che segue.
Niente di umano scoperchia la follia».
 *Marco Ercolani è psichiatra e scrittore. E’ autore di una vasta bibliografia che comprende saggi, romanzi e raccolte poetiche.
*Marco Ercolani è psichiatra e scrittore. E’ autore di una vasta bibliografia che comprende saggi, romanzi e raccolte poetiche.
Con Turno di guardia ha vinto nel 2010 il Premio Montano per la prosa inedita. Tra le sue ossessioni: i racconti apocrifi, le vite immaginarie, la poesia contemporanea e il nodo arte/follia.