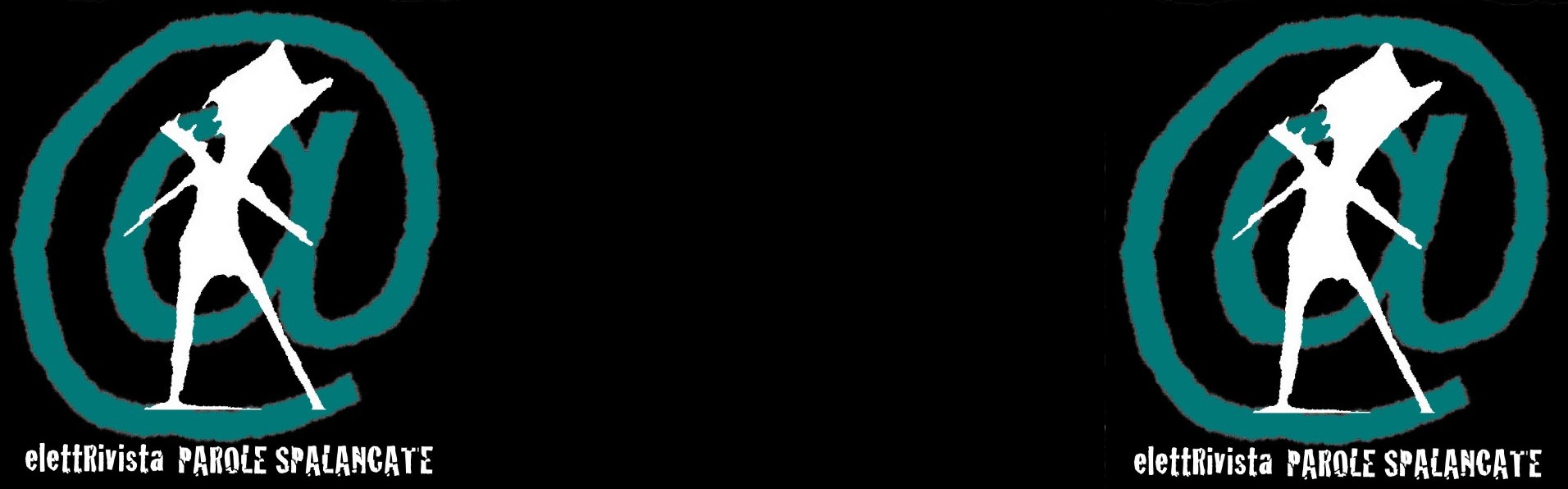11 Gen Stanze per la giostra
STANZE PER LA GIOSTRA
A cura di Massimo Morasso*
 Come tutti i mondi, anche quello della poesia è un mondo strano, dove l’equivalenza fra qualità e notorietà risulta spesso intransitiva, incongrua come potrebbe risultare un unicorno in una dissertazione di zoologia. La mia bislacca similitudine non vale tanto come invito a una rivalutazione revanscista di questo o quel poeta, quanto, direi, come una sorta di a-priori del pensiero critico: chi osanna i poeti cosiddetti maggiori, di solito non prende fischi per fiaschi, ma il più delle volte tende a farlo perché “così fan tutti”, e perché, con la montagna di libri che oggi si pubblicano, immagina che non valga la pena faticare sulle raccolte degli altri, i cosiddetti minori.
Come tutti i mondi, anche quello della poesia è un mondo strano, dove l’equivalenza fra qualità e notorietà risulta spesso intransitiva, incongrua come potrebbe risultare un unicorno in una dissertazione di zoologia. La mia bislacca similitudine non vale tanto come invito a una rivalutazione revanscista di questo o quel poeta, quanto, direi, come una sorta di a-priori del pensiero critico: chi osanna i poeti cosiddetti maggiori, di solito non prende fischi per fiaschi, ma il più delle volte tende a farlo perché “così fan tutti”, e perché, con la montagna di libri che oggi si pubblicano, immagina che non valga la pena faticare sulle raccolte degli altri, i cosiddetti minori.
Al di là di vagli e giudizi dei singoli esegeti, che sono sempre legittimi, c’è da chiedersi se sia davvero possibile che un buon lettore onesto di poesia possa farsi un quadro reale dello stato dell’arte del più negletto, e del più massivamente praticato, fra i generi letterari. Ammesso che la parola del critico vada un po’ più lontano rispetto a quella del giornalista acculturato (le due funzioni, ormai, fuor d’Accademia tendono a coincidere), la produzione dei poeti più o meno giustamente invisibili si merita o no l’affondo dei segugi del “poetico” disseminato fra migliaia e migliaia di versi? Magari se ne gioveranno i tanti mediocri, mai sazi di cartine pubbliche di tornasole del loro estro musaico, ma, in fin dei conti, farlo o non farlo, quell’affondo, che differenza fa?
Uno dei problemi che si pone è se perda di più un autore “sommerso” a non essere letto da un critico come-si-deve – da un essere intuitivo, cioè, in grado di lasciarsi guidare dall’opera di un altro essere umano per estrarne con intelligenza il succo quintessenziale –, oppure il critico, rifiutandosi di seguirne il percorso a pro di quelli, assai più esposti in evidenza, dei pochi “salvati”. A perderci, di certo, sarà il lettore carente o privo di gusto musaico, che si aggira (magari felice ma) disorientato fra i versi in cui s’imbatte, su rivista o sui social, con la stessa dabbenaggine che ha il caccia-bestseller in un megastore.
A proposito della dialettica fra sommersione e salvazione, Primo Levi ci ricorda che, in un contesto nel quale è il pensiero unico a dominare, «sopravvivono i peggiori, cioè i più adatti; i migliori muoiono tutti». Ragion per cui, per contribuire anch’io a far sì che il pensiero possa continuare a disunirsi, moltiplicandosi nel labirinto di un fruttuoso, ingovernabile plurale, d’accordo con Claudio Pozzani ho deciso di dar contezza pubblica di qualche esperienza di qualche esperienza di lettura aliena dal mainstream, che ho fatto, faccio e continuerò a fare “in purezza”, senza secondi fini – aborrendo io, in particolare, il più volgare fra di essi, il letterariamente imperante do ut des.
Dando avvio alla cosa, mi affido a un nume tutelare: Agnolo Ambrosini detto Poliziano, che reputo un maestro fra i maestri dell’artigianato verbale, e al quale rubo il titolo di questa rubrica. L’operina geniale Stanze per la giostra (1475-1478) di Poliziano mi ha insegnato infatti, trentanove anni fa ma una volta per tutte, che un testo poetico risulta tanto più poetico quanto più è intriso di memoria poetica. Circostanza che ha più di un suo perché, visto che l’intreccio fra memoria e immaginazione è a un tempo il propulsore e la sostanza della poesia.
Dico quasi lo stesso in forma di domanda: non è forse vero che a parità di qualità fantastica e tenuta ritmica, un testo-patchwork pieno di rimandi, costruito con una logica sottotestuale a mosaico, ha molte più probabilità di un testo giocato su una tastiera eminentemente “sentimentale” di mettere in moto i nostri neuroni motori del piacere estetico? La si pensi come si vuole, a me la poesia che interessa è quella che non tradisce la consegna della riflessione nella forma e nella lingua, piegandosi alle sragioni dell’immediato, pur senza cadere nelle secche dell’intellettualismo. Credo che salterà agli occhi, scorrendo le mie note. Le quali, in ogni caso, daranno la possibilità di leggere il presente post-novecentesco della poesia italiana, saltabeccando fra qualche raccolta degna d’attenzione, alla ricerca di quella varietà prospettica del “vero” poetico che estromette dal sonno della propaganda.
Ma basta con le considerazioni generali. Ringrazio Claudio (Pozzani), che mi ospita, ed entro nel merito.
ALESSANDRO RICCI
 A più di vent’anni, ormai, dall’inizio del nuovo secolo si sta iniziando a capire che certe gerarchie non sono indiscutibili. Nel Novecento, si sono date esperienze poetiche tuttora semi-sconosciute, che sono degne di essere collocate al livello della migliore letteratura rubricata dalla critica accademica e dalla storiografia “ufficiale”. Il caso straordinario di Alessandro Ricci, poeta altissimo e negletto, è esemplare…
A più di vent’anni, ormai, dall’inizio del nuovo secolo si sta iniziando a capire che certe gerarchie non sono indiscutibili. Nel Novecento, si sono date esperienze poetiche tuttora semi-sconosciute, che sono degne di essere collocate al livello della migliore letteratura rubricata dalla critica accademica e dalla storiografia “ufficiale”. Il caso straordinario di Alessandro Ricci, poeta altissimo e negletto, è esemplare…
Ci sono degli autori che sembrano fatti apposta per rimanere nell’ombra. E non essere quasi neanche letti, per il tempo breve della loro vita (che in letteratura è un tempo piccolo, assai poco significativo). Con la conseguenza, giocoforza, di non risultare per nulla “influenti” sulle generazioni immediatamente successive alle loro, nel senso, perlomeno, in cui la critica di solito ragiona d’influenza, questo prodotto ambiguo della bilancia quantitativa.
Di tanta discreta genia di scrittori inattuali in forte credito di stima, Alessandro Ricci è senz’altro uno dei campioni più dotati. Per molti motivi, che possono essere ridotti, insomma, a due: per la novità e la potenza di rappresentazione, e la forza simbolica ed espressiva di tanta parte di ciò che ha concepito. “Poeta vero, molto raffinato, forse troppo lucido”, come pare ne abbia detto un lettore dell’acume di Giorgio Caproni, Ricci (Garessio, Cuneo, 1943 – Roma 2004) nell’ultimo trentennio del secolo scorso ha scritto poesie quasi sfacciatamente fuori tempo, estendendo la sua visione tragico-esistenziale essenzialmente contemporanea a una temporalità passata acquisita come storica. I suoi versi li ha scritti in un “modo” strano e molto raffinato, appunto, esercitando il suo virtuosistico talento del dettaglio per vie di minimi scarti tonali fra narratività e lirismo. Il che, va da sé, non dice nulla su ragioni e sragioni della sua quasi totale invisibilità, e della pesante cappa di silenzio che è calata per così dire fin da subito sulla sua opera.
Ma il fatto è che Ricci era un uomo schivo e appartato, tutt’altro che presenzialista, senza smanie napoleoniche da “primo della classe” né voluttà di auto-rappresentazioni esagerate; un uomo, dunque, fin troppo schivo e appartato, per ambire a salire da protagonista sul proscenio pieno di fantocci sgomitanti della società dei poeti. Eppure, non si fa opera di coraggio critico nell’affermare, come faccio, che è (stato) un poeta fra i più notevoli della seconda metà del Novecento, in Italia. Anche se quasi nessuno se ne è accorto. Può bastare la lettura di Gli ibis, a dar evidenza della levità e dell’eleganza ritmico-prosodica del suo dettato, e della malinconica felicità immaginativa di una mente che era capace di “accendersi” di fiamma d’amore di fronte alla memoria di un mondo amato e perduto sì, eppure vivo e presentissimo.
Gli ibis
Lo schiavo sudanese del porto
di Massilia, sfinito dai pesi
e dalla sferza, vede calare
dall’oneraria un mazzo convulso
di ali e becchi nella rete,
e sono atrocemente,
fra le risate della ciurma,
ibis rossi della Nubia.
Per gli eleganti horti dei capi
trascinati fin qui.
Lui che li vide accendersi
nei canali, e volare sui loti
e le canne in lente
file al crepuscolo, o intuìti
altissimi sulla savana, numi
in quella terra felice.
Aveva forse dieci anni.
Quella gran polvere all’orizzonte.
Chi diceva antilopi dalla Libia,
invece apparvero le coorti nùmide
che l’avrebbero preso.
 *Massimo Morasso è saggista, critico letterario, traduttore e poeta. Germanista di formazione, ha studiato a fondo la poetica di R.M. Rilke e Yvan Goll. Ha scritto vari libri su e come Vivien Leigh ,l’ampio zibaldone metaletterario Il mondo senza Benjamin e il ciclo poetico de Il portavoce (con vari editori fra il 1997 e il 2012). Dirige le edizioni Contatti e la rivista “AV”.
*Massimo Morasso è saggista, critico letterario, traduttore e poeta. Germanista di formazione, ha studiato a fondo la poetica di R.M. Rilke e Yvan Goll. Ha scritto vari libri su e come Vivien Leigh ,l’ampio zibaldone metaletterario Il mondo senza Benjamin e il ciclo poetico de Il portavoce (con vari editori fra il 1997 e il 2012). Dirige le edizioni Contatti e la rivista “AV”.