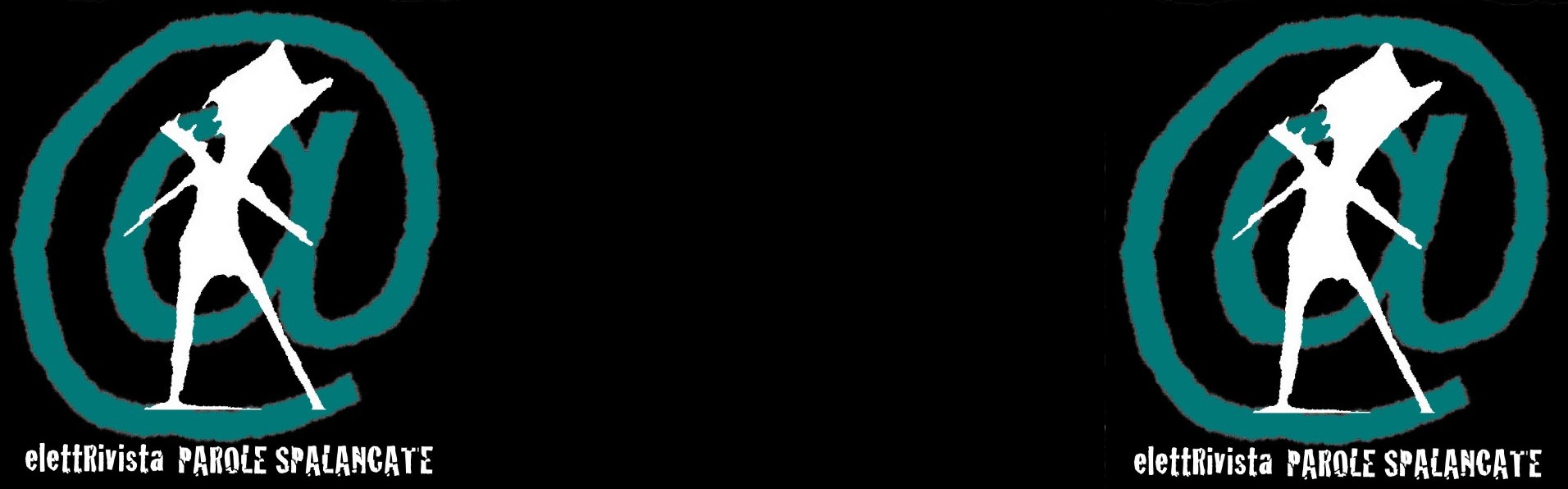06 Apr Scenari artistici – Interviste
SCENARI ARTISTICI – INTERVISTE. Dialoghi con gli artisti partecipanti al Festival Internazionale di Poesia di Genova
Rubrica di Laura Capra*
Inizia oggi, con l’intervista a Domenico Brancale, la nuova rubrica Scenari Artistici – Interviste a cura di Laura Capra.
 – Domenico Brancale –
– Domenico Brancale –
«Non sarò mai al sicuro/dentro la parola»
Dall’epigrafe che apre L’ossario del sole (Passigli, 2007), Scenari artistici – Interviste si apre oggi a Domenico Brancale.
Poeta e performer che fa della parola il suo smarrimento, visitato dalla voce che renderà scrittura l’ormai già-passato presente, siamo in ciò che dovrà ancora avvenire. Parlano il respiro, la morte, la carne, il sangue, lo spazio dell’accadimento e la certezza di ascoltarci nella possibilità di fare a meno di noi stessi.
Non ci troviamo in Lucania e nemmeno a Venezia o Bologna, luoghi cari a Brancale; siamo immersi nel cyberspazio.
Domenico, in questo periodo di attesa contingentata non mi è possibile intervistarti dal vivo come differentemente sarebbe stato e pertanto ci affideremo alla tecnologia; come stai?
Chiedilo a Lazzaro! Non potrei dirti veramente come sto. E poi stiamo in tanti modi e “come stai” ha perduto la sua anima. Non è altro che un intercalare in cui ci abbandoniamo ogni qualvolta incrociamo un nostro simile. Ma ci siamo mai chiesti come stesse Lazzaro dopo essere ritornato a vivere, che cosa avesse fatto negli anni successivi. Nessuno guarda sotto il sasso per non inorridire. Sarebbe terribile. Non facciamo nessuno sforzo. In realtà ci teniamo a debita distanza dall’altro con frasi di questo genere “come stai, capisco e compagnia bella”. Quanta ipocrisia sgorga dai nostri pensieri. A pensarci bene non ho mai fatto qualcosa per l’altro che non mi riguardasse. Non è questione di egoismo. Credo soltanto che non si possa aiutare l’altro facendo a meno del proprio io. Solo raggiungendosi scopriamo l’altro. Per fare ciò è necessaria e imprescindibile una certa rivolta proprio verso se stessi. Non dimenticando mai quei diritti che Baudelaire riteneva sacrosanti: il diritto di contraddirsi e il diritto di andarsene.
Allora, “come sto?”.
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Appeso alla vita e sempre pronto a staccarmi. Basta poco, un refolo, un’emozione all’improvviso e via, via da questo stare. Puff… Zvanì… Evaporati. In questi ultimi tempi c’è una corsa all’apparire, al fare, tutti vogliono creare, vogliono, vogliono, volere e non potere. Io in qualche modo desisto, all’accanimento che serbo per il vivere contrappongo il “desistere”, uno star fermi, una rinuncia all’ambizione. Del resto ogni cosa è destinata al fallimento. La morte è il traguardo più importante del fallimento. Tutto porta lì. Non possiamo farci nulla. Ora, si tratta, soltanto di godersi la vita fin quando si può. Senza troppe pretese se non quelle che soddisfano le nostre possibilità e non le volontà. Forse se c’è uno scopo nella poesia è quello di prepararci alla morte. Scavare nell’anima, scavare a fondo, per trovare la soglia che possa contenere l’accettazione della morte.
Vorrei lasciare a te la scelta di una frase per aprire questa intervista
Da un po’ di tempo al risveglio mi ripeto sistematicamente una frase “Omero era cieco, nessuno poteva vederlo” in cui ritrovo la lezione di Jean Cocteau. Un poeta dovrebbe essere invisibile, guardare oltre il proprio sguardo. Perché in un certo senso farsi cieco è farsi parola.
Direi, ogni uomo che è veramente un poeta tenta in qualche modo di uccidere il poeta che c’è in lui e deve assolutamente ucciderlo se vuole che esista una poesia veggente, una poesia che ci apra gli occhi su ciò che non possiamo ancora vedere, che renda reale la realtà. La scrittura come la magia non crea ma invoca. I veri maghi sono quelli che fanno riapparire qualcosa che è sempre stato dinanzi a noi, che non si è mai mosso, ma che per svariati motivi non riuscivamo a vedere. I veri maghi sono quelli che ti dicono: “Ecco, lo vedi il sole, ora te lo faccio riapparire”.
La tua ultima partecipazione al Festival Internazionale della Poesia di Genova fu nel giugno 2019, una stagione storica differente rispetto all’attuale e per tale ragione ti domando: quale suono, immagine, parola, poi divenuto ricordo, associ all’ultima edizione del festival?
Quella dei festival è un’esperienza che ci può arricchire o impoverire umanamente. Tutto sta nell’incontro. A dire il vero, non ho mai cercato la poesia in un festival. La poesia è nell’essere scrittura e libro. Nei festival di poesia s’incontra la voce. La voce del corpo della poesia. Questa voce può confermare il nostro amore o smentirlo, è come se davanti al poeta la poesia stessa potesse ritrarsi, quando le due cose non coincidessero. Ho bei ricordi dell’edizione del festival di Genova a cui ho partecipato, è stato un modo per ritrovare alcuni amici che incontravo per la prima volta come Lucetta Frisa, Marco Ercolani, Luciano Neri, e soprattutto ho ritrovato il mare.
E mi vengono in mente le parole dello scultore Giacinto Cerone che dinanzi al mare mi ripeteva: “Davanti a questa immensità come puoi pensare di essere qualcuno o qualcosa”.
La situazione epidemica legata al Covid-19 ci ha reso al contempo ascoltatori e protagonisti; l’osservazione partecipata alle nostre sorti, l’accettazione di ciò che è divenuto il nostro nuovo spazio quotidiano e la costruzione di una nuova vita, a partire da ciò che è accaduto e non si è ancora del tutto configurato. In questa nuova visione penso al concetto di spazio: fisico, temporale, emotivo.
Dal tuo punto di vista, con quale modalità possiamo accostarci alla parola?
Come bambini, come analfabeti. Per un analfabeta la parola nasce sempre la prima volta. Solo spogliando il nostro sapere dal sapere di sapere, da tutte quelle convinzioni che lo rendono morto. Ponendo l’orecchio di nuovo sul suono, sulla voce, sulla musica, su una parola non ancora sterilizzata, fino al silenzio.
Ogni poesia in qualche modo è un’interrogazione che promette il silenzio. O meglio, la sola promessa che una poesia può mantenere è quella del silenzio.
Sì, bisognerebbe accostarsi alla parola come un neonato al capezzolo della madre che succhia, succhia fino al midollo osseo della vita.
Correlandoci al suono della parola… possiamo udirla? In qualche modo mi sovviene il tuo concetto «soltanto la parola che ascolta può parlare»
Sai, è molto semplice la questione, come un sordo non può parlare così accade alla parola. Prima di pronunciarsi ha dovuto ascoltare qualcosa che non conosceva, l’inaudito che sta nelle cose.
Ma per arrivare a questo, prima di tutto, il faut destituire la lingua. Un compito arduo in questa epoca dove la chiacchiera impesta a destra e a manca, a discapito della voce.
Come dicevo, può risultare difficile, ma grazie a questa deposizione della lingua – nel senso di deporre la parola dalla croce della lingua – la parola risorge, proprio nel punto in cui avevamo visto bruciare tutte le speranze. Una sola parola, tenace più di tutte le altre. Una parola a malapena udibile, sprofondata nel sangue, che ci rifiuta e all’improvviso ci avvolge, che scolpisce il silenzio. Una parola che ci ignora a tal punto da dimenticare chi l’ha pronunciata. Una parola che non si rivolge che a se stessa.
In un ciclostile dedicato all’acqua, apparso nella collana Fotocopie della libreria Modo Infoshop, distante tre anni dal tuo ultimo libro Per diverse ragioni (Passigli, 2017) tratti del rapporto con la vita, la morte, la possibilità, ne affronti le conseguenze, il «gettarsi nel niente» quando «le parole non sono mai il fine. Qualche cosa galleggia. Qualche cosa affonda»; cosa ti ha spinto a condividere con il lettore questa riflessione, lucida, attraverso un percorso a tratti sott’acqua?
A Paestum esiste una tomba, conosciuta come Tomba del Tuffatore. Sulla lastra di copertura è raffigurato un uomo nudo, sospeso in aria, che si tuffa in uno specchio d’acqua. Si tuffa per raggiungere la voce non ancora voce, la voce prima del corpo. Ogni poesia è l’iscrizione del tuffo nella parola. È trattenere il respiro fino alla morte.
Per ritornare alla tua domanda. Le mie poesie nascono accanto a queste riflessioni sotto forma di diario di corrispondenza. L’immagine che mi rappresenta è quella di uno scultore che scolpisce e che oltre alla scultura decide di mostrare gli scarti, le schegge, i frammenti, la polvere tutto ciò che di solito viene raccolto e buttato via. Questo per dire che spesso le cose che ci formano sono proprio quelle che non riteniamo importanti, le più insignificanti. Sono loro che a nostra insaputa incidono l’anima.
Il processo di creazione accomuna tutti gli artisti sebbene sia a tratti fase inconsapevole; il viaggio rappresenta per molti, fonte concreta d’ispirazione e rinnovamento. In questo momento di “fermo” come si può rinnovare l’ispirazione?
In realtà non stiamo mai fermi, anzi in un periodo di stasi come questo, senza saperlo e senza volerlo, compiamo viaggi abissali dentro di noi che al cospetto un viaggio in un’isola sperduta nel Pacifico sembra una passeggiata.
Non esiste ispirazione senza espirazione, è una questione di vocali e di respiro. Se vuoi, l’ispirazione viene dall’esterno da ciò che conosciamo (è un fenomeno che potremmo dire attivo) mentre l’espirazione scaturisce da dentro di noi, dalla nostra parte oscura e ignota (è un fenomeno passivo). E poi esiste l’aspirazione, ancora un’altra vocale in gioco e un altro respiro, che sarebbe il tentativo di legare l’espirazione all’ispirazione. La poesia è una sorta di matrimonio tra il cosciente e l’incosciente. Per rinnovare l’ispirazione è necessario questo dialogo tra dentro e fuori.
Per ciascun poeta vi sono stati dei punti di riferimento sebbene poi durante il percorso alcune di queste voci si siano consolidate ed altre abbiano lasciato il posto a poetiche anche distanti, rispetto alla propria, le quali però Per diverse ragioni sono riuscite a giungere. Quale voce poetica senti maggiormente vicina in questo momento?
Il cammino di ogni uomo è costellato da incontri con l’altro. Dipendiamo completamente dagli altri. Sono tante le stelle che continuano a brillare nel buco del mio firmamento poetico e che non smetto di fissare: la stella di Rimbaud, di Alexandr Blok, Marina Cvetaeva, Benjamin Fondane, Paul Celan, Thomas Bernhard, Clarice Lispector. Oggi la voce che sento più vicina è quella degli Oracoli caldaici. Per me sono la prova schiacciante che l’impossibile è una dichiarazione d’amore fatta dalla voce alla parola, la più impossibile delle possibilità.
Collegandoci alla tua attività lavorativa presso la Galerie Bordas a Venezia ti chiedo quale opera d’arte sceglieresti per rappresentare la particolarità di questo momento storico
Credo di non aver mai scritto un verso senza tener presente davanti a me un’opera di un artista o un altro. È una sorta di finestra da cui sporgersi per respirare. La chance che ho di vivere parte della mia vita in una galleria d’arte come quella di Hervé Bordas è impagabile. Poter intravedere nelle opere il gesto dell’artista fino a scorgerne quasi la mano è edificante. Non bisogna dimenticare che osservare un quadro è instaurare un dialogo. Ora ritornando alla tua domanda, l’opera d’arte che a mio avviso rappresenterebbe questo momento è “Il cane” di Giacometti. E “ho detto tutto” come direbbe il principe Antonio de Curtis. Cioè niente. In quella scultura ci sono i nostri passi, il respiro delle nostre solitudini.
Vuoi anticiparci in merito ai tuoi progetti prossimi?
Poiché non ci si bagna mai due volte nello stesso libro, e non si può leggere due volte una frase nel medesimo stato, in questi giorni ho ripreso in mano “Mal d’acqua” il ciclostile di cui parlavi, per un’edizione nuova e ampliata che dovrebbe uscire prossimamente in un libro per una casa editrice a me cara, le Edizioni degli Animali.
Mentre per le edizioni “Prova d’Artista” della Galerie Bordas ho tradotto le lettere che Antonin Artaud scrisse all’editore Pierre Bordas per la pubblicazione del suo Artaud le Mômo. Il libro andrà in stampa in questi giorni e sarà accompagnato da alcune grafiche originali, fuori testo, di un’artista che stimo moltissimo, Nicola Samorì, del quale ti consiglio una mostra, la prima antologica dell’artista, che verrà inaugurata l’8 aprile a Bologna, nelle sale di Palazzo Fava.
Il lavorio di traduzione mi sta molto a cuore perché permette di allontanarmi da quella parte di vita, troppo presente, troppo invadente. È un viaggio a rebours verso la propria lingua – l’apprendistato di un linguaggio nuovo. A volte rimango mesi, anni senza scrivere poesie. È terribile, ma in fin dei conti fa parte della mia natura. Tra una parola e l’altra spesso scorrono secoli. E scrivere non è altro che affrontare questo viaggio, mettersi in cammino. Tutti i poeti si mettono in cammino il 20 gennaio. Una data che è inscritta nel Dna della parola.
Abbiamo aperto l’intervista con una frase; se volessimo lasciare parlare la parola come significante e come significato, cosa ci direbbe oggi?
Oggi, non ci direbbe niente.
Grazie Domenico.
Nota biografica:
Domenico Brancale è uno scrittore nato In Basilicata. Tra i suoi libri ricordiamo: L’ossario del sole (2007), incerti umani (2013), Per diverse ragioni (2017) e Scannaciucce (2019) che raccoglie tutti i suoi testi in dialetto lucano. Ha tradotto alcuni autori come Cioran, John Giorno, Michaux, Claude Royet-Journoud, Giacinto Scelsi. È uno dei curatori della collana di poesia straniera “Le Meteore” per Ibis e “Prova d’Artista” per la Galerie Bordas. Il suo lavoro sulla voce e sullo spazio ha prodotto le azioni: Questa deposizione rischiara la tua assenza (Galleria Gasparelli, Fano 2009), un sempre cominciamento (galerie hus, Paris 2012), Nei miei polmoni c’è l’attesa (Galleria Michela Rizzo, Venezia 2013), incerti umani (Galleria de’ Foscherari, Bologna 2013), incerti umani (Festival Città delle 100 scale, Potenza 2013), Se bastasse l’oblio (MAC, Lissone 2014), Langue brûlé (Palais de Tokyo, Paris 2014), Scannaciucce – una lode dell’Asino (Matera 2019).
 * Laura Capra, è nata a Genova ed è specializzata nei settori risorse umane e comunicazione. Ha pubblicato la raccolta di poesie Nero Fittizio (Puntoacapo editore, 2020)
* Laura Capra, è nata a Genova ed è specializzata nei settori risorse umane e comunicazione. Ha pubblicato la raccolta di poesie Nero Fittizio (Puntoacapo editore, 2020)