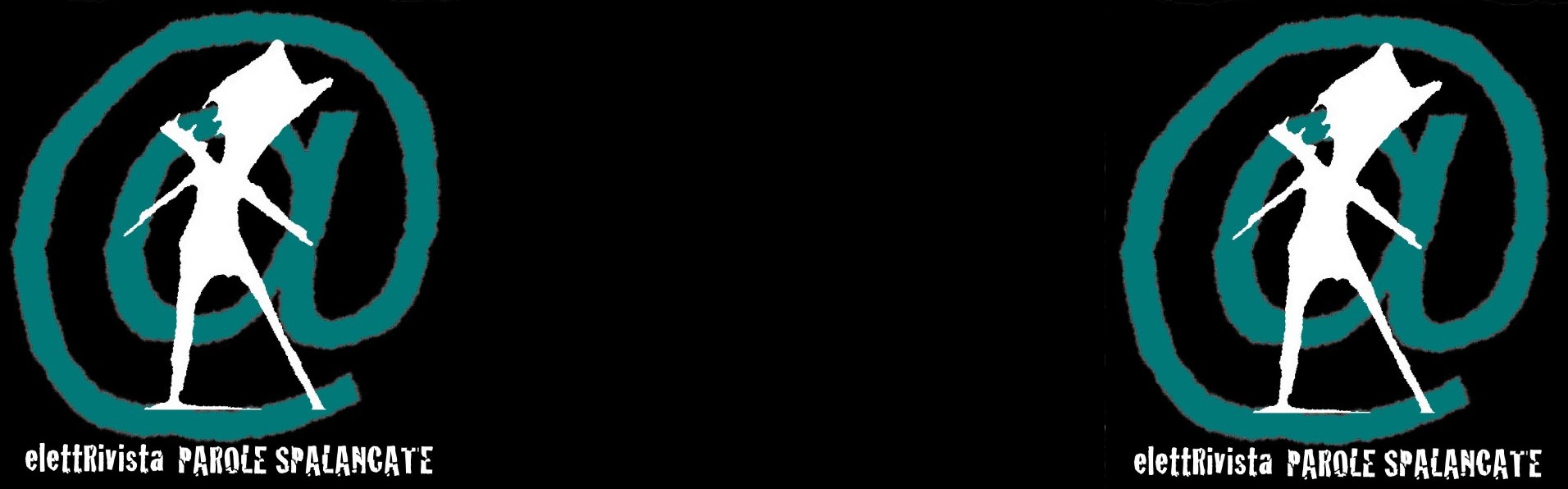10 Mar Poevisioni
POEVISIONI
Rubrica di Maurizio Fantoni Minnella*
LE VERITA’ DEL FILM DOCUMENTARIO D’AUTORE
 Ritenuto una parte fondamentale dell’apparato di propaganda politica nei regimi totalitari del ventesimo secolo, il documentario visse una propria vita duratura all’interno dei cinegiornali o nei programmi di divulgazione di massa del partito unico, a Roma come a Berlino.
Ritenuto una parte fondamentale dell’apparato di propaganda politica nei regimi totalitari del ventesimo secolo, il documentario visse una propria vita duratura all’interno dei cinegiornali o nei programmi di divulgazione di massa del partito unico, a Roma come a Berlino.
Sebbene operassero già attivamente da alcuni anni autori come Dziga Vertov in Unione Sovietica con il suo vivace e radicale sperimentalismo, John Grierson e Robert Flaherty, rispettivamente in Inghilterra e negli Stati Uniti, Luis Buñuel e Joris Ivens in Spagna e in Olanda, che proponevano, sia pur con modalità diverse, un cinema di sguardo profondo sul reale, osservato nelle sue pieghe più complesse, tuttavia per le masse popolari, il documentario resta pur sempre un episodio secondario, culturalmente irrilevante, il che spiega chiaramente il pregiudizio ormai ben radicato nell’immaginario collettivo, secondo cui vi debba essere necessariamente una separazione tra film e documentario, come se il secondo, nato con la nascita del cinema, non fosse cinema ma piuttosto qualcos’altro.
Con tale incongrua e ingiusta separazione si è proceduto sino ai giorni nostri, negando al film documentario qualsiasi titolo di “artisticità”.
Eppure nessuno si sognerebbe di negare alle opere dei maestri succitati l’importanza di alcuni loro capolavori come L’uomo con la macchina da presa, 1922, Las Hurdes, 1931, L’uomo di Aran, 1936, Borinage, 1933, sebbene si tratti pur sempre di eccezioni.
Ma a che cosa si deve la rinascita del film documentario che ha caratterizzato la produzione dell’ultimo ventennio?
Come è stato possibile che una nuova generazione di documentaristi in Europa e nel mondo, si sentano anche autori a tutti gli effetti?
In altre parole, cosa è cambiato nel modo di concepire e di vedere il documentario, inteso come altro cinema e non come non-cinema, come linguaggio altro e non come genere?
Innanzitutto va detto che sulla spinta data da due film importanti quanto emblematici, con nette caratteristiche d’autore, Buena Vista Social Club di Wim Wenders, 1999 e Farhenheit 9!11, 2004 di Michael Moore, si è davvero creduto di poter inaugurare una nuova stagione del documentario.
Evidentemente il significativo successo di pubblico di entrambe le opere, al di là di una più attenta valutazione estetica delle singole opere, ha avuto come effetto quello di generare un grande equivoco la cui principale ragione è piuttosto semplice. A fronte di quel successo, diciamo pure planetario, non vi erano e non vi sono tuttora, né una sufficiente educazione al film documentario d’autore, né tantomeno un’adeguata struttura produttiva e distributiva in grado di coprire le richieste sempre più numerose degli autori e conseguentemente, di arrivare ad un vasto pubblico.
Ciò nonostante, in Italia e all’estero si continua a realizzare film documentari con caratteristiche d’autore.
La conquista, davvero inaspettata del Leone d’oro a Venezia e l’Orso a Berlino da parte del filmaker romano Gianfranco Rosi, rispettivamente con Sacro Gra (2014) e Fuocoammare (2016), ha lasciato ben sperare, sia pur con comprensibili dubbi, in una nuova stagione del film documentario d’autore, che, in altre parole, significa riconsiderarne i valori espressivi come opera di cinema a tutti gli effetti.
Ma è grazie al modello ormai lontano fornito dall’americano Moore che molti registi esordiscono, proseguendo, nei casi più fortunati, la propria esperienza filmica, nella convinzione, mai veramente smentita, che la forma-documentario sia ancora la più idonea ed efficace ad esprimere il disagio e il malessere della realtà contemporanea, sia essa sociale o individuale. O comunque la sua complessità, tenendo sempre presente che le potenzialità tematiche del cinema documentaristico sono davvero infinite, laddove è lo sguardo sul reale l’anello di congiunzione tra l’opera e il proprio pubblico.
Per le grandi masse, esso continua a non essere neppure una parte minore dello spettacolo cinema, ma semplicemente altro rispetto alla tradizionale idea di cinema. E questo è un dato con il quale è necessario confrontarsi, sia dal punto di vista storico critico che da quello produttivo.
Nell’effettiva impossibilità di risolvere questo dualismo, si è progressivamente affermata una sorta di contaminazione dei due linguaggi che oggi viene comunemente definita docu-fiction, termine che sostituisce quello più appropriato di docu-drama. Una scelta (oggi sempre più diffusa e più cercata), che in fondo, soddisfa il bisogno di comunicare allo spettatore un’idea di finzione, di ricreazione della realtà, partendo però dai suoi dati sensibili.
Sebbene la sua nascita corrisponda esattamente alla nascita del cinema, il documentario, (nell’accezione mutuata dai fratelli Lumière), finì per risultare assai meno gradito del suo antagonista, il racconto d’invenzione fantastica del maestro illusionista Georges Meliès.
Da questi due archetipi, dunque, discende l’eterna seduzione del cinema: il gioco della realtà e quello della finzione.
 *Maurizio Fantoni Minnella è uno scrittore, saggista e documentarista italiano. Instancabile viaggiatore, ha realizzato oltre trenta documentari su biblioteche nel deserto, lavori notturni, problematiche mediorientali, storie di quotidiana resistenza e molti altri universi sociali, culturali, umani.
*Maurizio Fantoni Minnella è uno scrittore, saggista e documentarista italiano. Instancabile viaggiatore, ha realizzato oltre trenta documentari su biblioteche nel deserto, lavori notturni, problematiche mediorientali, storie di quotidiana resistenza e molti altri universi sociali, culturali, umani.